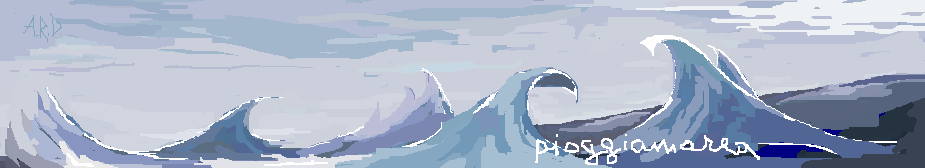Omosessualità. Necessita farne tragedia?
racconto breve di A.R.D.
dedicato alle vittime di omofobia
(dep.03/04/08 – tutti i diritti riservati – pubblicato in rete da maggio ’08)
(è consentito scaricare/stampare il racconto solo a scopo di personale lettura)
download (free – formato word – Nr. pagine 4)
(clic su download: poi Salva per scaricare nei tuoi Documenti;
oppure Apri per stampare subito e al termine usa la freccetta “indietro”)
(il racconto è intero: se appare il link “continua” cliccarvi per leggere tutto)
(Avvertenza: le regole grammaticali, in particolare per accenti e apostrofi,
non sono sempre rispettate, a favore di una più agevole lettura)
Le due tazzine fumanti sul vassoietto, la signora apre la porta:
– Marce’, il caf…
E il vassoietto, inox, non la finisce più di vibrare sul pavimento fra i cocci delle tazzine.
Marcello e Romoletto, staccatisi un po’ troppo tardi dall’abbraccio, fissano il loro caffè sul pavimento: sta là come sul luogo del delitto resta il lago di sangue.
– Ch’è successo?
La donna si gira al marito accorso, giornale in mano e occhiali calati fino all’estremo del naso, e risponde afona:
– Se stavano a bacia’… Se stavano a bacia’… L’ho visti io… Co’ st’occhi l’ho visti… Se baciavano come du’ innammorati…
– Piantala… – dice lui – Ce lo sai che se vonno bene come du’ fratelli. Se so’ dati un bacetto e tu stai a…
– No… che bacetto…? Come du’ innammorati te sto a di’! L’ho visti co’ st’occhi…
– Sta bona… Ora metto tutto a posto. In questi casi… bisogna parla’. Mo’ ce parlo… e sistemo tutto. So’ giovani… ponno sbaglia’… Va de llà… Qua ce penso io.
– Nun li mena’, sa’…!
– Ma va de llà! Du’ pezzi de marcantonio… li meno…
– Vado a rifa’ il caffè – e raccoglie il vassoietto – Coll’altra macchinetta… pure pe’ noialtri.
L’uomo scavalca cocci e caffè e con passo grave avanza nella stanzetta di Marcello; mentre dalla cucina giungono i rintocchi del cucchiaino contro il barattolo, piega il giornale e lo posa sulla scrivania, toglie gli occhiali e li posa sul giornale, ruota la sedia del computer, vi siede e fissa i due giovani che, seduti sul lettino, gli occhi bassi, si lanciano obliqui sguardi di incertezza.
Torna la signora completa di mocho, secchio, scopa e paletta. Pulisce il pavimento del caffè e poi spinge i cocci nella paletta manovrando la scopa di punta. Se ne va portando via tutto.
– Ndo’ volete arriva’? – chiede l’uomo.
I due giovani alzano a lui gli occhi, le fronti corrugate in un lungo silenzio.
Di nuovo torna la signora per la seconda passata di mocho. Di nuovo si allontana. L’uomo riprende:
– Vojo di’… che intenzioni ci avete?
– Serie – risponde Romoletto.
L’uomo salta in piedi:
– Nun me pija’ in giro tu, sa’? Io te strozzo! A tutti e due. Siete grandi e grossi ma er modo de strozzavve io lo trovo…!
– Vitto’… – giunge cantilenante dalla cucina il richiamo della moglie.
E il signor Vittorio si raschia la gola, si rimette seduto, resta corrucciato a pensare. Ma ecco che la fronte gli si spiana in una bella speranza e dice:
– Be’… è ’na cosa capitata oggi… così… Nun ve siete nemmanco accorti e ve siete aritrovati che…
– Stamo insieme da ’n anno e mezzo – informa Marcello.
L’uomo si sente mancare.
– Papà… papà…! – lo chiama Marcello.
– Sor Vitto’… A’ sor Vitto’… – lo sorregge Romoletto.
– E mo’ che è? – chiede la signora giunta con quattro tazzine.
Romoletto ne prende una e la porta alle labbra del suoc… del signor Vittorio.
Questi lo fissa con le sopracciglia sottosopra, e per la stizza si ripiglia subito: con una mano gli toglie la tazzina e con l’altra lo scansa.
I giovanotti si rimettono seduti sul lettino, la signora offre loro il caffè, poggia il vassoietto sulla scrivania e, attenta a mantener diritta la propria tazzina, volta il cuscinetto dello sgabello, per non sciuparne il già sciupato ricamo; e vi siede compita.
Bevono il caffè tutti e quattro a piccoli sorsi, con lunghi intervalli, come ad allungare il tempo.
La donna spia premurosa i gesti di ognuno e, quando è certa che tutti hanno finito di bere, si alza e impeccabile prende il vassoietto e fa il breve giro a recuperare le tazzine. Guarda il marito:
– Allora? Hai sistemato tutto?
– E come no? Tutto a posto.
– Ah, meno male – e riaggiusta il cuscinetto col ricamo in su – Allora io vado a ritirare i panni. Così poi apparecchio. Resti a cena, Romole’?
– Ma quanto sei gnoccolona…! – le dice freddo il marito – Secondo te basta ’na parlata?
– Io so’ gnoccolona…?! E nun l’avevi detto te che bastava ’na parlata?
– E non ho finito ancora. Oh.
La signora poggia di nuovo il vassoietto sulla scrivania, volta di nuovo il cuscinetto, a ricamo in giù, si rimette seduta, braccia tese e mani sulle ginocchia.
L’uomo ne distoglie gli occhi ruotando sulla sedia girevole fino a poggiare le braccia conserte sulla scrivania, la testa china. La solleva trovandosi di fronte il monitor spento, e resta a fissarlo. Ruota di nuovo:
– Ma voialtri… ve rendete conto che state a fa ’na cosa sbajata? ’Na cosa che è contro… come se dice…
– Contro natura – sospira la moglie.
– A’ pà…! E queste so’ idee da medioevo…!
– Ao’…! Che medioevo? Er monno è sempre uguale. E questa è proprio ’na cosa storta. Io… non ve voglio fa’ rimprovero… butta’ fori de casa… No. Ma voi dovete collabora’… Ce dovete da mette tanta bona volontà e supera’ la crisi.
– Che crisi?- chiede Romoletto.
– Ce sta a pija’ colle bone – spiega Marcello.
Il signor Vittorio si spazientisce:
– Ma benedetti figli…! Nun è mejo se state co’ ’na donna? Che ce trovate a… così tra de voi? Eh? Che ce trovate?
– Ma davero…! – concorda la signora – N’è mejo co’ le donne? A me… gli òmini… nun ce trovo proprio niente de bello.
– Eccola là… – si gira a fissarla il marito – E perché nun te ne sei stata co’ ’na donna tu? Invece da rompe l’anima a me…
– Io…!! E che me prendi pe’ quelle là? Quelle che se baceno tra de loro e…
– Te prendo pe’ la madre de questo ber campione.
– E mica l’ho fatto cor portiere! – alza le spalle lei.
Romoletto si schiarisce la voce; è in piedi:
– Io… allora… vado…
– Te ne vai…?! – stupisce la signora – Come sarebbe che te ne vai? E non stai a cena?! Ho fatto il polpettone coi carciofi alla giudìa. A te… te piaceno… Siedi, siedi…
– A proposito der porpettone… – annuisce il signor Vittorio guardandola – Mo’ ho capito perché tu’ fratello… tutti quei discorsi sui gay… l’altra sera…
– Tu la devi da smette de chiamallo polpettone – si risente lei.
– Io posso pure nun chiamaccelo, ma lui polpettone ce resta. E lasciamo perde lui… Ma me dici che figura ce famo quando lo sanno tutti quanti… de ’sti due?
– E che ce lo devono pe’ forza da sape’ ? Voi… non ce potete mette attenzione… così che nun se n’accorge nessuno?
– A’ ma’… e mica è ’na vergogna!
Il signor Vittorio annuisce di nuovo:
– Cesi’… guarda come te lo dico: questi, poco alla volta, metteranno li manifesti pe’ tutta Roma.
La signora se ne sta un po’ mogia. Quindi dice:
– A me non me ’mporta de nessuno… Me ce rode solo per gallinaccio affianco… la sora Agnesina. ’Sta soddisfazione proprio non gliela vorrei da’.
Alza le spalle:
– E pazienza. Io mo’ sai che faccio? Dico tutte le sere ’na preghiera. Po’ darsi che la Madonna ve fa guari’.
– A’ ma’…!
– Non è ’na malattia, sora Cesira – interviene Romoletto – Sì… è vero che ce stanno quelli che ’o fanno pe’ quarche problema… e ce se confònnono… Ma noi nun ce l’avemo ’sti problemi… Noi se sentìmo bene.
– Loro se sentono bene – annuisce ancora il signor Vittorio – Io me sento strippa’ la panza e loro se sentono bene.
– Mbe’ ? – dice la donna – E devono da sta’ male? Porelli…! Però, pure si non è ’na malattia, io la preghiera la dico lo stesso. Se guarite… bene. E se non guarite… vor di’ che Dio ve vole così. E se Dio ve vole così… po’ pure fa veni’ ’n colpo alla sora Agnesina… se trova da di’ qualcosa.
– Ecco, brava – approva il marito – Ma spiègate bene quando parli colla Madonna e co’ Dio: er colpo deve da esse pe’ a sora Agnesina… e no pe’ me.
– Ma che stai a di’? Mica un colpo è ’na cosa che se po’ chiede addentro a ’na preghiera! Se Dio vole… se ce pensa da solo… Ma nun se po’ chiede. Ce deve pensa’ da solo. Pure ’sti du’ figlietti so’ anime battezzate… e li deve da protegge. Be’… io vado a ritirare i panni… – si alza – …così poi apparecchio. E tu perché non te finisci quelle cose…?
– Quali cose? – stupisce il signor Vittorio.
La signora rimette a posto il cuscinetto, a ricamo in su, prende giornale e occhiali e glieli mette in mano, prende il vassoietto e col mento gli fa segno di uscire dalla stanzetta:
– Devi da fini’ quelle cose che stavi facenno prima.
Rientrando in cucina bisbiglia:
– Pare brutto a resta’ de llà… Vorranno sta’ un pochetto soli…
– Ah, non voglio certo regge er moccolo – ribatte l’uomo mettendosi seduto al tavolo.
– E che fai a fa’ ’sto tono? Nun te lo ricordi quanno a noi ce piaceva de resta’ un pochetto soli?
– A’ Cesi’… e nun è la stessa cosa…!
– E che ne sai? Po’ esse de sì. Boh…
E va a ritirare i panni. Tornata in cucina accende sotto il polpettone per scaldarlo; apre il cassetto, prende la tovaglia e la dispiega:
– Ma dimme ’n po’… Come… Vojo di’… Uno dei due deve fa la donna… no? Secondo te chi…
– Nun te ’mpiccia’! – scatta lui – Questi so’ fatti loro. Che ne so… Forse nun la deve da fa’ nessuno… Boh…! Ma comunque… Marcellino… nun po’ esse.
Stende con mano distratta qualche pieghina della tovaglia:
– ’N anno e mezzo… ’Sta storia dura da ’n anno e mezzo. E so’ grandi ormai… fanno pe’ davero.
La signora Cesira mette i tovaglioli e le posate:
– Be’… sai che c’è? Forse ce semo risparmiati l’impiccio de ’na nora rognosa. Mica le ragazze so’ più quelle de ’na volta…! Tutte ’ste sgallettate che se vedono in giro… Romoletto invece… è proprio un bravo ragazzo.
– E’ un bravo ragazzo sì! – e il signor Vittorio si allunga ad aprire lo stipetto basso a prendere la bottiglia di vino cominciata a pranzo – E poi noi… ormai… già glie volemo bene. So’ du’ anni che vie’ pe’ casa…
La signora Cesira mette i bicchieri:
– E pure la famiglia è brava gente. A proposito… chissà come la prenderanno.
– E come la devono da prende? – si acciglia un poco il signor Vittorio versandosi un dito di vino – Pure Marcellino nostro è un bravo ragazzo…! E come famija… semo mejo de loro.
E beve il dito di vino.
La moglie gira il polpettone per farlo scaldare anche dall’altra parte:
– Sai che sto a pensa’…? Se proprio deve da esse… se ponno sistema’ qua. Nella stanza da pranzo nun ce se mettemo mai… Famo porta’ via tutto che io so pure stufa de puli’ le vetrinette. Ce se ponno mette loro. E poi… la casa è nostra, e un domani… a morte nostra… li lasciamo sistemati.
– C’è pure la cantinola… – riflette lui – Ce sta quella roba vecchia… se po’ butta’… Romoletto ce se po’ sistema’ tutti l’attrezzi.
La donna si lascia i fornelli alle spalle e lo guarda:
– Embe’! Questo mo’… è proprio un mistero – si mette i pugni sui fianchi, il mestolo in un pugno – Dimme ’n po’… Come se spiega che se c’è da stura’ un lavandino… o da sistema’ ’na presa… aggiusta’ ’na manija… pitta’ li muri… a Romoletto glie piace da fallo e lo sa fa’… e pure Marcello ce riesce… e tu invece non sai nemmanco pianta’ ’n chiodo?
F I N E
marzo 2008, A.R.D.
qui per tornare alla home page